Archivio di Novembre 2012
La creatività e gli scacchi.
 Lo spunto per questo post sono due articoli letti ieri sul web: il primo, scritto dal Prof Woland sul blog di Luigi Bruschi, parla di una ricerca sul declino della creatività; il secondo, scritto dall’amico Alex Wild, annuncia il suo prossimo ciclo di 4 anni di scacchi scolastici a 9 classi di seconda primaria.
Lo spunto per questo post sono due articoli letti ieri sul web: il primo, scritto dal Prof Woland sul blog di Luigi Bruschi, parla di una ricerca sul declino della creatività; il secondo, scritto dall’amico Alex Wild, annuncia il suo prossimo ciclo di 4 anni di scacchi scolastici a 9 classi di seconda primaria.
Il primo articolo parla di una sperimentazione condotta su 300.000 americani, bambini e adulti, sottoposti al test Torrance del pensiero creativo dal professore associato di psicologia dell’educazione presso il College William & Mary a Williamsburg (Virginia) Kyung Hee Kim, e denuncia sostanzialmente una preoccupante diminuzione del pensiero critico e della creatività, intesa come propensione a ricercare diverse soluzioni al problema piuttosto che una strada univoca (come invece vorrebbero la logica e l’intelligenza). L’articolo è citato a corredo della recente esperienza dell’autore di insegnare gli scacchi in una quarta elementare di Firenze e per questo motivo ho avuto modo di leggerlo; mi ha semplicemente ricordato di una somministrazione dello stesso test da parte di una laureanda in Scienza dell’Educazione dell’Università degli Studi di Sassari, Eleonora Frunzio, ad una classe che aveva fatto scacchi con me per tre anni: dalla prima alla terza elementare. I dati raccolti dalla tirocinante e vagliati da un’equipe coordinata dal responsabile del reparto di neuro-psichiatria infantile del Policlinico sassarese, prof. Giuseppe Tola, e dal ricercatore dell’Università di Sassari dott. Arcangelo Uccula, dovevano servire da “sondaggio” (ne furono somministrati di svariati tipi) per privilegiare un’ipotesi di lavoro per una ricerca longitudinale da svolgersi negli anni successivi (progetto poi accantonato per mancanza di fondi). Ma i risultati furono subito giudicati molto interessanti proprio per ciò che concerne la creatività, spiccatamente superiore alla classe gruppo di controllo nella sperimentazione.
Ciò che posso confermare secondo la mia decennale osservazione è che gli scacchi abituano al ragionamento analitico, ma non con rigore matematico, bensì rinforzando il cosiddetto pensiero divergente o laterale: la scelta delle varianti giocate negli scacchi scolastici non è frutto di schematismo ma di un approccio personalissimo al problema. E qui vengo all’articolo di Alex Wild, che scrive appunto del suo ruolo di osservatore nei corsi di scacchi scolastici: lo scopo è quello di fare emergere spontaneamente sia l’interesse che la motivazione semplicemente con l’elemento ludico degli scacchi, senza interferire (errore che fanno molti istruttori “sportivi” alle loro prime esperienze nelle scuole) nei processi psichici dei bambini.
Il motivo di questo atteggiamento, che condivido appieno, è quello di favorire una libertà ed originalità di pensiero e di studiarne (con uno spirito davvero scientifico) le naturali evoluzioni. Potrei citare innumurevoli casi di soluzioni brillanti ai quesiti posti ai miei allievi, ma credo che chiunque abbia a che fare con la fantasia dei bambini abbia capito cosa intendo dire: il mondo visto dai bambini è spesso molto più ricco da quello proposto dagli adulti, quindi il compito dei bravi educatori non deve essere quello di uniformare tutti verso un ipotetico “migliore” ragionamento, ma di comprendere invece le istanze e la sensibilità delle proposte “diverse” suggerite dai bambini.
Senza i pedoni per scudo sembra l’esercito nudo.
Introduzione: la difesa è un’arte dimenticata?
Quante volte, analizzando una partita persa, ci siamo resi conto che la sconfitta non è arrivata per un attacco brillante dell’avversario, ma per una nostra difesa imprecisa? Nel mondo degli scacchi, siamo affascinati dagli attacchi spettacolari e dai sacrifici geniali, ma spesso trascuriamo la sottile e potente arte della difesa, un’omissione che ci costa innumerevoli punti.
È qui che entra in gioco la saggezza di Mark Dvoretsky, un allenatore leggendario che ha formato generazioni di talenti. I suoi insegnamenti rivelano una verità fondamentale: la difesa non è un’attesa passiva, ma una strategia complessa, attiva e ricca di risorse sorprendenti. È un’abilità che va studiata e padroneggiata.
Questo articolo esplora tre lezioni difensive controintuitive ma potentissime tratte dal lavoro di Dvoretsky. Ci concentreremo su un aspetto specifico e spesso sottovalutato: come trasformare i propri pedoni in un impenetrabile scudo difensivo per salvarsi anche nelle posizioni più difficili.
Lezione 1: la fortezza inespugnabile — salvarsi contro ogni pronostico
Il primo concetto chiave che Dvoretsky ci insegna è quello della “fortezza“, la forma definitiva dello scudo di pedoni. Una fortezza è una struttura difensiva così solida da poter garantire un pareggio anche quando un giocatore si trova in significativo svantaggio di materiale. È l’ancora di salvezza definitiva quando tutto sembra perduto.
Un esempio lampante si trova nella partita Wolff-Browne (Campionato USA, Durango 1992).
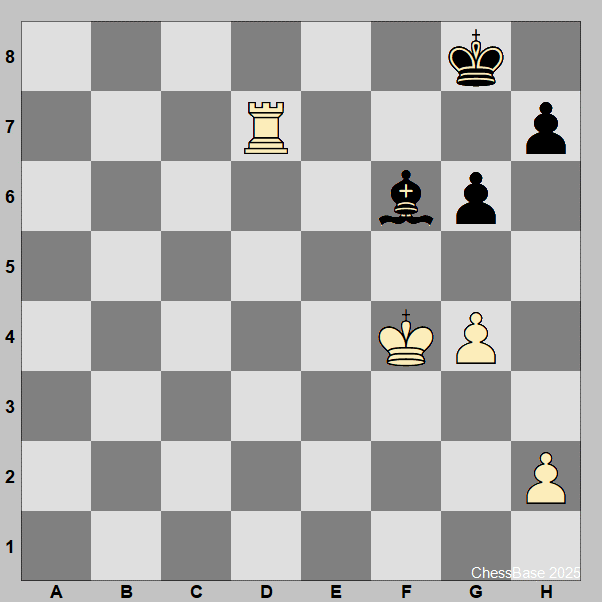
In una posizione di finale considerata persa da molti, il Nero avrebbe potuto costruire una fortezza inespugnabile posizionando i pedoni in h5 e g6. Questa specifica configurazione rende impossibile per il Re avversario avvicinarsi e attaccare i pedoni, neutralizzando così l’arma vincente principale della parte in vantaggio. Come sottolinea Dvoretsky con rammarico da esperto, “Ma, ahimè, nessuno dei due giocatori conosceva questa posizione“. Una lacuna di conoscenza critica, persino a livello di grandi maestri.
Questo concetto è dirompente perché dimostra che posizioni considerate perse a livello amatoriale sono in realtà patte teoriche. Rivela l’importanza di una profonda conoscenza dei finali e trasforma la nostra percezione di ciò che è possibile ottenere in una posizione difficile.
La parte più debole mira a costruire una fortezza, mentre la parte più forte mira a impedirne la costruzione o (se è già stata costruita) a trovare un modo per distruggere le difese dell’avversario.
Lezione 2: il re non è un passeggero, è il guardiano dello scudo
La seconda lezione fondamentale riguarda il ruolo del Re come guardiano dello scudo di pedoni. Una solida struttura di pedoni non è sufficiente da sola; il Re deve essere un partecipante attivo nella difesa.
Dvoretsky evidenzia una tecnica cruciale chiamata “spallata” (Shoulder-charge). Si tratta di un vero e proprio scontro fisico tra i due monarchi, in cui il nostro Re usa il proprio corpo per spingere via il Re avversario dalla zona critica protetta dallo scudo di pedoni. Nella partita Alekhine-Bogoljubow (Campionato del Mondo, 1929),
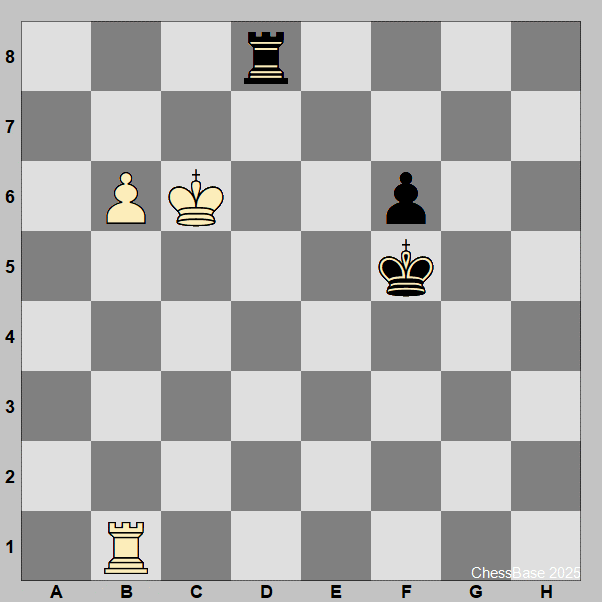
Bogoljubow mancò la mossa salvifica 70… Re4!. Questa mossa segue una legge difensiva fondamentale: “Il Re nero deve essere posizionato sul percorso del Re avversario“. Non è una buona mossa; è l’unica mossa che obbedisce al principio, creando una barriera insormontabile e assicurando la patta.
Allo stesso tempo, Dvoretsky mette in guardia contro il pericolo correlato: permettere che il proprio Re venga costretto a tornare sull’ottava traversa. Questo evento conduce alla sconfitta. Quando il Re viene respinto sulla traversa di fondo, non può più avanzare per sostenere lo scudo di pedoni. Questo singolo evento frantuma la coordinazione difensiva e trasforma una posizione patta in una persa. Questa lezione sfida la comune errata convinzione che la sicurezza del Re significhi passività. Al contrario, il Re è un pezzo combattente di grande potenza, essenziale per mantenere l’integrità dello scudo difensivo.
Lezione 3: la strana logica degli alfieri contrari — quando il colore giusto è quello sbagliato
La terza lezione ci porta nel cuore della tecnica dei finali, svelando una regola tanto specifica quanto controintuitiva per la costruzione di uno scudo di pedoni in finali con alfieri di colore contrario. In questi finali, come insegna Dvoretsky, le posizioni non vanno “giocate“, ma “costruite“. L’obiettivo non è reagire, ma erigere una struttura teoricamente inespugnabile.
La saggezza convenzionale, insegnata ai principianti, impone di posizionare i pedoni su case di colore opposto al proprio alfiere per massimizzarne la mobilità. Dvoretsky smantella questa idea con una logica profonda e paradossale: per ottenere una fortezza solida, la parte in svantaggio dovrebbe posizionare i propri pedoni su case dello stesso colore del proprio alfiere.
La logica dietro questa regola è impeccabile. Un pedone difeso dal proprio alfiere è invulnerabile all’alfiere avversario, che si muove su case di colore opposto. Questo lascia il Re nemico come l’unico pezzo in grado di attaccarlo, un compito che il nostro Re può facilmente impedire. Questa conoscenza profonda e non ovvia è un marchio di fabbrica della tecnica magistrale e trasforma quello che sembra un semplice finale in una ricca sfida strategica.
Conclusione: i vostri pedoni, i vostri mattoni
Le lezioni di Mark Dvoretsky ci ricordano che la difesa è un’arte ricca di profondità e di risorse inaspettate. Per trasformare i nostri pedoni in un impenetrabile scudo difensivo, abbiamo appreso tre principi fondamentali: l’idea della fortezza come risorsa salvifica definitiva, il ruolo del Re come guardiano attivo e fisico dello scudo, e l’importanza di una conoscenza tecnica profonda, come la costruzione di fortezze con alfieri di colore contrario.
Questi non sono solo concetti da memorizzare. Sono una direttiva strategica: smettete di considerare la difesa come un ripiego e iniziate a vederla come un’opportunità per dimostrare abilità, tenacia e creatività. La difesa non è subire, ma costruire.
La prossima volta che vi troverete sotto pressione, vedrete i vostri pedoni come semplici ostacoli o come i mattoni per costruire la vostra salvezza?
